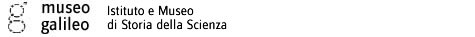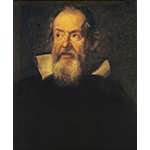Teologi irati (1632-1633)
A Roma qualche copia del Dialogo fresco di stampa piombò in un'atmosfera quanto mai inquinata, fra fumi controriformistici ed intricate vicende politiche legate alla guerra dei trent'anni. Sul fronte internazionale Urbano VIII subiva fortissime pressioni dalla Spagna che non sentiva adeguatamente sostenuta dai forzieri papali la propria campagna militare antisvedese, mentre sul fronte interno era sempre meno dissimulabile e meno tollerata una prassi incentrata sul più meschino familismo. Sentendosi assediato da dentro e da fuori, il papa, ormai nella più totale insicurezza, si diede a una mirata epurazione delle proprie file. Una delle prime teste a cadere fu quella di Giovanni Ciampoli, accademico linceo e amico intimo di Galileo, che perse la carica di Segretario dei brevi segreti ai principi.
Intossicava ancor più l'aria il malanimo degli anticopernicani, in particolare dei Gesuiti, che, memori dell'irrisione e delle cocenti sconfitte inflitte loro da Galileo negli anni precedenti, dovevano «sotto mano lavorar gagliardissimamente» per far proibire l'opera. Lo riferiva Filippo Magalotti al Guiducci, citando alla lettera quanto aveva udito con le proprie orecchie da Niccolò Riccardi: «i Giesuiti lo perseguiteranno acerbissimamente». Fra i più gagliardi, probabilmente, lo Scheiner, la cui «rabbia canina» contro Galileo aveva preso mille forme nella sua Rosa Ursina, un testo di astronomia pubblicato poco tempo prima. Già durante l'ultimo soggiorno romano, non estranea un'azzardata frequentazione del monaco vallombrosano Orazio Morandi poco dopo incarcerato a vita per aver predetto la morte del papa, Galileo era stato oggetto di maldicenze e calunnie, ignorate per miracolo nelle alte sfere, che avevano tendenziosamente attribuito anche a lui oroscopi e funerei vaticini di pari irriverenza. Dopo la pubblicazione del Dialogo, per screditarlo agli occhi del papa non era neppure necessaria una particolare inventiva: bastava semplicemente soffiare sul fuoco. Pur a un primo frettoloso esame, infatti, il Dialogo non era proprio piaciuto. «Che il libro si trattenga, e non passi costì; senza che di qui si mandi quello che s'ha a correggere, né meno si mandi fuori», scriveva il Padre Mostro all'Inquisitore fiorentino, chiedendo poi se i tre delfini in circolo col motto grandior ut proles, cioè più grande come la mia discendenza, posti in calce al frontespizio, fossero una trovata originale di Galileo. Non fu facile convincerlo che comparivano su tutti i libri pubblicati da Giovambattista Landini, perché evidentemente l'insegna del tipografo doveva aver incendiato la coda di paglia del Barberini che vi aveva letto una pesante allusione alle facili sistemazioni di fratelli e nipoti nelle posizioni chiave della curia romana. Il papa era tanto sospettoso quanto infuriato. Non aveva affatto apprezzato che il suo infallibile argomento dell'onnipotenza divina, quiete per l'intelletto, non fosse, come richiesto, la conclusione ultima e inconfutabile del Dialogo, la pietra tombale sulle velleità umane di ricerca, ma fosse stato «posto in bocca di Simplicio, personaggio… molto poco stimato, anzi più tosto deriso e burlato». Con l'ambasciatore Francesco Niccolini, pur stemperando l'offesa personale, troppo poco rappresentativa di Cristo, non era riuscito a frenare la stizza: Galileo «haveva ardito entrar dove non doveva», in combutta col Ciampoli aveva aggirato gli obblighi imposti in cambio dell'approvazione, sostenendo una «dottrina… perversa in estremo grado», trattando addirittura la «più perversa materia che si potesse mai haver alle mani». Di lì a poco il Ciampoli fu trasferito in un paese di montagna delle Marche. Quanto il suo allontanamento fosse legato al presunto filoispanismo e quanto allo stretto legame con Galileo è difficile dire. L'ossessione del tradimento e del complotto e la scarsa considerazione in cui era stato tenuto il suo parere avevano trasfigurato nel Barberini l'antica adulazione in una delusione molto più perniciosa per l'adulato che per l'adulatore.
Fu dato l'ordine di rintracciare e sequestrare le poche copie del Dialogo in circolazione. Tommaso Campanella avvisava Galileo che stava per riunirsi una «congregatione di theologi irati» formata da membri di vari ordini religiosi, col compito di esaminarne scrupolosamente il testo. «Dubito di violenza di gente che non sa», si preoccupava, e, dimostrando uno scarsissimo senso della realtà, chiedeva che il Granduca di Toscana spingesse per farlo entrare nella commissione, insieme a Benedetto Castelli, in qualità di avvocato difensore. Il padre Castelli, dopo qualche tentativo di mediazione miseramente naufragato, si sarebbe dato alla macchia e lui, già all'Indice per un'Apologia pro Galileo scritta a seguito delle accuse del 1616, si voleva garante delle sorti del Dialogo e dell'incolumità del suo autore: «ha fatta un'opera quasi simile che fu prohibita, né potrebbe difendere mentre è reo», avrebbe tagliato corto il Padre Mostro. Alla fine il Campanella si rispondeva inconsapevolmente da solo sul patrocinio insensato della causa galileiana: «se non la vincemo mi tenga per bestia». Infatti la commissione si riunì, ovviamente senza di lui, composta unicamente da ''gente che non sapeva'': il teologo personale del papa, un gesuita ungherese e il Padre Mostro medesimo, che esibiva amicizia e benevolenza, ma, dovendo scagionare se stesso per l'imprudente approvazione concessa al Dialogo, si trovava, giudicante e giudicato, al centro di un pesantissimo conflitto di interessi.
Scandagliato il Dialogo, la commissione affidò a un documento scritto l'elenco minuzioso delle sue colpe. All'edizione fiorentina era stato apposto l'imprimatur di Roma senza un ordine preciso e senza avvertire chi lo aveva concesso (e il Riccardi se l'era cavata). Il tono conciliante del proemio non trovava rispondenza nell'ostentata sicurezza del resto dell'opera, dove la «medicina del fine» (cioè la argomentazione conclusiva imposta da Urbano VIII) era stata messa «in bocca di uno sciocco», e ben seppellita «che né anche si trovava se non con difficoltà», tanto più «approvata… dall'altro interlocutore freddamente». Spesso l'eliocentrismo non era presentato come ipotesi matematica, ma asserito in assoluto, con argomenti stringenti, mentre le prove contrarie erano date per impossibili. La struttura dell'universo non era presentata come presupposta (naturalmente secondo un sistema geocentrico), ma come ancora da definire. Gli autori anticopernicani, considerati dalla Chiesa come punti di riferimento, venivano bistrattati. L'intelletto umano era assimilato al divino «nel comprendere le cose geometriche». Era dato come verità che molti tolemaici si fossero convertiti al copernicanesimo e non viceversa. Il «flusso e reflusso» del mare, fenomeno «esistente», era stato imputato al moto della Terra e alla stabilità del Sole, cause «non esistenti».
Tutto questo, proseguiva il documento, si sarebbe anche potuto correggere, se si fosse vista «qualche utilità nel libro», ma c'era ben altro, la cui gravità era inemendabile. Con la pubblicazione del Dialogo Galileo aveva contravvenuto ai decreti del Sant'Uffizio seguiti al processo del 1616, in base ai quali la teoria eliocentrica non si poteva tenere, insegnare o difendere in qualsivoglia modo, a parole o per iscritto. Sorprende che l'unico documento fin lì noto, cioè la lettera chiarificatrice inviata a suo tempo dal cardinale Bellarmino a Galileo, non specificasse la questione con altrettanta precisione, formulando un divieto generico di tenere o difendere la mobilità della Terra: da dove nasceva la proibizione di insegnarla in qualsivoglia modo, a parole o per iscritto?
La serietà della situazione, si stabilì, imponeva un coinvolgimento del Sant'Uffizio nell'affare, e il papa se ne rammaricava con ingannevole compassione. Ma, d'altra parte, Galileo era «entrato in un gran ginepreto, nel quale poteva far di meno» occupandosi di «materie fastidiose e pericolose», per di più «dannate» sedici anni prima. Non c'era nulla da fare. Il Sant'Uffizio, in breve, si riunì. Bastò la lettura del documento della commissione a far avviare un processo inquisitoriale e a Galileo fu dato un mese di tempo per presentarsi a Roma a rispondere personalmente dei suoi crimini. Vecchio, malandato e a quel punto anche terrorizzato, Galileo tentò tutte le strade per evitare il viaggio, dalle lettere di supplica all'intercessione degli amici. L'ambasciatore Francesco Niccolini presentò una richiesta ufficiale di dispensa e di fronte al secco rifiuto del papa, gli spiegò a quattr'occhi che, viste le precarie condizioni di salute, l'età avanzata, le difficoltà dello spostamento e la sofferenza per le pesanti accuse, Galileo avrebbe rischiato la vita. «Venisse pian piano in lettiga e con ogni suo commodo», fu la risposta pietosa, nella speranza che Dio gli perdonasse «l'errore d'essere entrato in un intrigo come questo», quando lui stesso, ancora cardinale, «ne l'aveva liberato».
Sfumata ogni illusione di evitare il processo, Galileo ebbe un tracollo psicofisico. «S'è messo in letto et corre pericolo di andare più all'altro mondo che costà», scriveva da Firenze Andrea Cioli, Segretario granducale, al Niccolini a Roma. Si chiese più di una proroga, col supporto di certificati medici che davano un quadro tetro (anche se piuttosto stravagante) della salute di Galileo, il cui polso era «intermittente di tre o quattro battute» per una «facultà vitale impedita e debilitata assai» in quella «età declinante», ma probabilmente anche per il «patire di vertigini frequenti, di melancolia hipocondriaca, debolezza di stomaco, vigilie, dolori vaganti per il corpo», nonché di «un'hernia carnosa grave con allentatura del peritoneo». I referti, pur così scientifici, non furono creduti veritieri al Sant'Uffizio che sotto la minaccia di inviare a Firenze medici e funzionari per «condurlo alle carceri» inquisitoriali «legato anco con ferri», fecero sì che Galileo si risolvesse a partire per Roma, temendo più le prigioni che l'interrogatorio. Disgraziatamente l'uno non escludeva le altre.
****************************
Scheda a cura di Sara Bonechi
Data aggiornamento 16/gen/2008