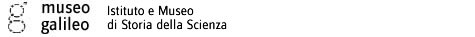Bilance (1619-1623)
La polemica non si fermò qui e andò ben oltre, nel tempo e nei contenuti. Galileo nel Discorso delle comete non era stato affatto tenero col suo avversario e tanto meno lo era stato col vero bersaglio dei suoi strali, Tycho Brahe, morto e sepolto per lui dentro e fuor di metafora. Neppure il Collegio Romano dei Gesuiti ne era uscito indenne, per una serie di abbagli presi all'interno della scuola di matematica riguardo alle osservazioni telescopiche delle comete. Ostilità e risentimento contro Galileo cominciarono ovviamente a montare negli ambienti della Compagnia e maturò fra i veleni l'idea di una replica, affidata ancora una volta al padre Grassi. Sotto lo pseudonimo di Lotario Sarsi uscì, sempre nel 1619, la Libra astronomica ac philosophica. Se dal titolo (libra in latino significa bilancia) ci si sarebbe aspettati una certa pacatezza e ponderazione (peraltro ostentata ogni piè sospinto dall'autore) nel soppesare le varie teorie sulle comete, in realtà l'opera sprizzava rancore e astio da ogni virgola. Pur con qualche giusto rilievo a certe incongruenze logiche del Discorso, talvolta disinvolto quanto alla conseguenza delle argomentazioni, la Libra non riusciva ad uscire dagli usuali canoni scolastici, avendo perciò pochi mezzi, oltre all'aggressività verbale, per controbattere le eccezioni di fondo sollevate da Galileo e Guiducci.
Galileo replicò a sua volta. Non subito. Dopo qualche anno, sotto il patrocinio dell'Accademia dei Lincei, che dedicò l'opera al nuovo papa Urbano VIII, Maffeo Barberini al secolo, il cardinale che in occasione degli sventurati fatti del 1616 era stato uno degli oppositori meno radicali delle teorie copernicane. Era il 1623. Stando a una lettera del linceo Francesco Stelluti, il padre Grassi, solo a vedere il frontespizio del volume appena stampato, «si cambiò di colore», ché se il contenuto valeva il titolo, per lui c'era poco da stare allegri. Galileo aveva scritto Il saggiatore, nel quale con bilancia esquisita e giusta si ponderano le cose contenute nella ‘Libra astronomica e filosofica' di Lotario Sarsi Sigensano. Il saggiatore era la bilancia di precisione dell'orafo, la libra era la stadera dell'ortolano. Lo sfottò preliminare anticipava i propositi di Galileo: combattere col rigore scientifico la grossolanità argomentativa del rivale. Il tono ironico e tagliente dello scritto non inganni: non si trattava affatto di una risposta colpo su colpo alle animosità del Grassi. Galileo si divertiva sì a suggerirgli titoli alternativi per la sua opera, come L'astronomico e filosofico scorpione, per via delle punture velenose che aveva ricevuto, giocando coi doppi sensi sui nomi delle costellazioni (Libra era anche il nome latino della Bilancia), ma pur con fare impertinente e talora anche pedante, ribatteva punto per punto, nel merito, all'intero trattato. Andando ben oltre le questioni cometarie da cui partiva, Il saggiatore si rivelava anche un vero e proprio discorso sul metodo, quando attaccava frontalmente un modo di procedere nell'indagine naturalistica (quello della tradizione aristotelica, fatto proprio dalla cultura cattolica) superato dagli eventi e tenuto ormai in vita artificialmente, per ragioni, oltretutto, che nulla avevano a che vedere con la volontà di giungere alle vere cause dei fenomeni. Oggetto della ricerca scientifica non erano, per Galileo, i libri dei poeti, «come l'Iliade e l'Orlando furioso, libri ne' quali la meno importante cosa è che quello che v'è scritto sia vero», ma «questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto dinanzi agli occhi», cioè «l'universo». Già in passato Galileo aveva ironizzato sui naturalisti da biblioteca, che non volevano mai «sollevar l'occhio da quelle carte, quasi che questo gran libro del mondo non fosse scritto dalla natura per esser letto da altri che da Aristotele». La frustata era duplice. Colpiva da un lato il principio d'autorità, perno del procedere scolastico, basato unicamente sulle opinioni degli scrittori e sul confronto dei testi, mentre nella realtà, al contrario, «la forza delle umane autorità» risultava priva di ogni valore «sopra gli effetti della natura, sorda e inessorabile ai nostri vani desiderii». Colpiva poi anche i mezzi espressivi della cultura dominante, che Galileo considerava «un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto». Il linguaggio comune non era quello proprio della filosofia naturale, perché il libro dell'universo era «scritto in lingua matematica», e i caratteri di questa lingua erano «triangoli, cerchi ed altre figure geometriche». Visto però che «il ridursi alla severità di geometriche dimostrazioni è troppo pericoloso cimento per chi non le sa ben maneggiare», gli studiosi di tradizione aristotelica, ignari di matematica, si erano sempre rifugiati in «limitazioni», «distinzioni», «istorcimenti di parole», o in spericolate «girandole» che tutto avevano portato, fuori che un reale progresso nella conoscenza della natura. Galileo vedeva nelle acrobazie linguistiche dei suoi oppositori un modo per sottrarsi all'ineluttabilità della dimostrazione, l'unica via che con concisione e immediatezza conduce a stabilire senza mezzi termini il vero o il falso. Lo spiegava a modo suo con un'immagine fra le più eleganti: «nelle dimostrazioni necessarie... è forza in brevi parole ed al primo assalto restare o Cesare o niente». E confermava anche, al di là della padronanza della lingua matematica, di non essere secondo a nessuno nelle raffinatezze del linguaggio comune.
Di fronte a tanta scienza la tattica dei Gesuiti si rivelò in capo a qualche anno per quello che era: agitare lo spettro del carcere ogniqualvolta la teoria non venisse loro in soccorso. Nel 1626 il padre Grassi, nell'ennesima replica, isolò un passo del Saggiatore, dove Galileo considerava come intrinsecamente proprie dei corpi solo alcune caratteristiche, come moto, figura, numero, dimensioni (cioè tutto quanto ci sia di misurabile), le quali - sosteneva - dipendono dall'attività di «una moltitudine di corpicelli minimi» che compongono la materia. Le altre, come sapore, colore, odore hanno un valore unicamente per i nostri organi di senso che le percepiscono, e non sono niente relativamente ai corpi e alle loro prerogative fisiche: «puri nomi», diceva Galileo. Ma «nell'ostia è comunemente affermato che il calore, il sapore, e così via, permangano», chiosava il padre Grassi. «Si dovrà dunque inferire - continuava - che Galileo sostiene che il calore e il sapore non sussistano nell'ostia. L'animo prova orrore solo a pensarlo!». Con un colpo di mano la discussione fu spostata dal piano scientifico, dove il confronto era impari, a quello teologico, dove il confronto era inammissibile. E lo spettro del carcere si aggirò davvero per Roma: il Sant'Uffizio cominciò ad esaminare l'opera di Galileo (che pur qualche anno prima aveva ottenuto senza problemi l'imprimatur) per individuarne tutti i luoghi dove il suo serpeggiante atomismo avrebbe potuto violare la dottrina cattolica dell'eucaristia e il dogma della transustanziazione.
****************************
Scheda a cura di Sara Bonechi
Data aggiornamento 16/gen/2008