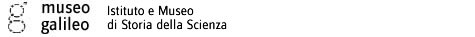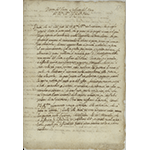Principio di secol novo (1632)
Si promulgò a gli anni passati in Roma un salutifero editto, che, per ovviare a' pericolosi scandoli dell'età presente, imponeva opportuno silenzio all'opinione Pittagorica della mobilità della Terra. Non mancò chi temerariamente asserì quel decreto essere stato parto non di giudizioso esame, ma di passione troppo poco informata... Per tanto è mio consiglio nella presente fatica mostrare alle nazioni forestiere che di questa materia se ne sa tanto in Italia, e particolarmente in Roma, quanto possa mai averne imaginato la diligenza oltramontana... A questo fine ho presa nel discorso la parte Copernicana, procedendo in pura ipotesi matematica, cercando per ogni strada artifiziosa di rappresentarla superiore, non a quella della fermezza della Terra assolutamente, ma secondo che si difende da alcuni che, di professione Peripatetici, ne ritengono solo il nome, contenti, senza passeggio, di adorar l'ombre, non filosofando con l'avvertenza propria, ma con solo la memoria di quattro principii mal intesi.
Con questi avvisi del proemio Al discreto lettore Galileo pensò di aver messo al sicuro il suo Dialogo, dove nei congressi di quattro giornate si discorre sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano, proponendo indeterminatamente le ragioni filosofiche e naturali, tanto per l'una, quanto per l'altra parte, uscito a Firenze nel 1632 e dedicato al nuovo Granduca di Toscana Ferdinando II de' Medici. In effetti in queste poche righe c'era tutto l'indispensabile: il copernicanesimo presentato come ipotesi matematica; il sostegno al moto terrestre inteso non in assoluto, ma solo come critica metodologica alla setta peripatetica che l'avversava; la censura del 1616 definita salutifera contro gli scandali e gli odori di eresia; l'intero libro addirittura esibito come una difesa degli ambienti ecclesiastici romani, accusati di ignoranza all'estero, dove certe proibizioni non avevano mai impedito l'approfondimento scientifico. Che cosa chiedere di più?
Ottenere l'imprimatur, però, non era stata affatto una passeggiata. A Firenze la cosa era corsa piuttosto spedita. Ma a Roma il Maestro del Sacro Palazzo, Niccolò Riccardi, genovese, aveva inspiegabilmente tardato. Galileo vi aveva a che fare da un po', fin dai tempi del Saggiatore (era stato lui a formalizzarne l'approvazione). L'aveva conosciuto personalmente in occasione del viaggio a Roma nel 1624. Era soprannominato il Padre Mostro, per la strabiliante memoria, pare, e più che altro perché non doveva essere un gran che a vedersi. Il Riccardi non era mai stato particolarmente accanito contro le novità celesti e aveva sempre considerato necessario tener separato il piano scientifico da quello scritturale. Ma era mente modesta: «si quieta in un suo modo assai spedito di mettere angeli che, senza difficoltà o intrico veruno, muovano i corpi celesti così come vanno», lo ritraeva Galileo, sconcertato più dalla quiete che dagli angeli. Nel 1630 aveva letto il manoscritto del Dialogo senza sollevare alcuna eccezione, dando la sua approvazione per l'edizione romana, che poi non si fece. Strano che un anno dopo, avendo richiesto di visionare unicamente il proemio e l'epilogo, rinviasse in continuazione il proprio parere sull'edizione fiorentina. Francesco Niccolini, ambasciatore toscano a Roma, fece la voce grossa e alla fine il Riccardi diede la sua autorizzazione alla stampa, pretendendo però una sorta di liberatoria scritta che lo cavasse di responsabilità. Si capiva che era pressato dall'alto, da molto in alto. In ultimo, non nascose di agire sotto il diretto impulso di Urbano VIII, e inviò all'inquisitore fiorentino una lettera con le sue esplicite richieste. Oltre alle note precauzioni, diligentemente inserite da Galileo nel proemio, il papa desiderava che, secondo le sue personali opinioni, si evidenziassero «le ragioni della divina onnipotenza... le quali devono quietar l'intelletto», e che l'opera, sia nel titolo che nel contenuto generale, non riguardasse assolutamente il «flusso e reflusso», cioè il problema delle maree. Singolare pretesa, quest'ultima.
Con tutti i crismi e i permessi, non senza correzioni apportate dal Padre Mostro al proemio, di lì a qualche mese il volume era pronto. Il Dialogo era il frutto non solo delle esperienze ''sensate'' di scienziato, ma anche dell'esperienze vissute di uomo. A cominciare dai personaggi. Galileo aveva voluto tributare un omaggio a due dei suoi amici più cari, che lo avevano lasciato già da qualche tempo: Giovanfrancesco Sagredo, l'amico veneziano, rappresentato come una sorta di novello Socrate copernicano (così lo vide Campanella, ma in realtà, si direbbe, una proiezione di se stesso), e Filippo Salviati, l'amico fiorentino, disegnato come l'interlocutore acuto, intellettualmente onesto e privo di preconcetti. Immaginario il terzo personaggio, tal Simplicio, il peripatetico, un concentrato di tutti i vizi dell'aristotelismo, preda dei pregiudizi più ottusi. Galileo spiegava nel proemio che il suo era un caso di omonimia con l'antico commentatore di Aristotele, ma a nessuno sfuggì la provocatoria assonanza del suo nome con la semplicità dei suoi pensieri.
La patina di cautela imbellettava solo il proemio. Per il resto il Dialogo era tutto un mulinare di durlindana contro i fondamenti del mondo aristotelico e contro la «viltà inaudita» di tutti quegli «ingegni servili» incapaci di ribellarvisi. Galileo aveva messo a frutto decenni di lavoro e aveva ripercorso tutte le tappe che lo avevano portato alle convinzioni copernicane. La falsità dell'incorruttibilità dei cieli smascherata grazie al telescopio, con l'osservazione della Luna e delle macchie solari, la cui deformazione ottica gli aveva fatto ipotizzare un'inclinazione dell'asse di rotazione del Sole rispetto al piano dell'orbita della Terra; l'inconsistenza di un centro unico dell'universo, coincidente con quello della Terra, confutata con le conoscenze acquisite sul moto dei gravi; la staticità terrestre contraddetta non solo dalla scarsa plausibilità dei velocissimi tempi di rotazione della sfera celeste, ma anche dall'osservazione al cannocchiale del comportamento degli altri pianeti del sistema solare e dalla misurazione delle loro orbite. Mitologie millenarie sul moto dei gravi, pretese dimostrazioni contrarie alla mobilità terrestre, tolte di mezzo con un'unica prova, quella della relatività del moto, secondo la quale all'interno di una struttura in movimento, per esempio una nave (ma potrebbe essere la Terra), il moto impresso alla struttura contenente è «comune a tutte le cose contenute in essa ed all'aria ancora» e quindi, relativamente a tutti i moti interni alla struttura, è «come se non fusse». In altri termini, il volo di una mosca all'interno di una nave (o la caduta di un grave sulla Terra) accadrà nello stesso modo sia che la nave (o la Terra) si muova, sia che stia ferma.
E ce n'era per tutti, per Aristotele, per Tolomeo, per Tycho Brahe (e, malauguratamente, anche se di rinterzo, per i loro seguaci ancora in vita). Un attacco a tutto campo sferrato con un linguaggio essenziale, a volte caustico, ma allo stesso tempo penetrante e in certi casi anche lirico, comunque mai banale, dove ogni parola ha il proprio esatto significato, quello e solo quello, coglie il centro del problema senza chiacchiere astratte, e non può dar adito a fraintendimenti. Il che fa del Dialogo non solo uno dei testi capitali della scienza moderna, ma anche un capolavoro letterario, dove si parla di fisica con la lingua della poesia. Vi traspare, accanto a uno sviscerato amore per la verità, una certa fascinazione per la natura e i suoi fenomeni, quasi umanizzati nelle descrizioni del loro aspetto e dei loro comportamenti. Quella Luna sensuale, piena di «eminenze e cavità», simili alle nostre «più alte e scoscese montagne», di «scogli staccati e solitari, ripidi assai e dirupati», di pianure che contengono «un monte rilevato assai» o «materia alquanto oscura». Quel suo rapporto ambiguo con la Terra, alla quale rivolge sempre la stessa faccia, «quasi allettata da virtù magnetica», che «in ricompensa» delle «notti assai chiare», le riflette a sua volta i raggi del Sole «quand'ella n'è più bisognosa», salvo poi risponderle «non meno alle offese che ai favori», togliendole la luce con l'eclisse. Quelle «mosche, farfalle e simili animaletti volanti», quei «pescetti» guizzanti che contribuiscono a illustrare il principio della relatività del moto. Oltre a un'osservazione quasi maniacale della vita quotidiana, per spiarne eventuali agganci alle teorie scientifiche: sete, velluti, madreperle, diamanti, marmi, strumenti musicali, suppellettili varie e piccole meschinità umane, fra quelli «che sanno per lo senno a mente tutta la poetica, e son poi infelici nel compor quattro versi solamente» e gli altri che «posseggono tutti i precetti del Vinci, e non saprebber poi dipignere uno sgabello».
Si affacciava anche, dalla trattazione scientifica, quell'audace idea dell'uomo per sua propria indole spinto alla conoscenza, in una ricerca continua e inesauribile, che, verità dopo verità, si avvicina sempre di più a capire le leggi che regolano l'universo, anche se «non è effetto alcuno in natura, per minimo che e' sia, all'intera cognizion del quale possano arrivare i piú specolativi ingegni». Galileo aveva sì chiuso il proemio del Dialogo ribadendo diplomaticamente di contrastare la «fermezza della Terra» seguendo solo un «capriccio matematico», non per ignoranza, ma per «il conoscimento della divina onnipotenza e la coscienza della debolezza dell'ingegno umano». Ma poi non era riuscito a frenare l'entusiasmo che in realtà la fiducia nelle capacità della ragione umana gli suscitava. «Non posso trovar termine all'ammirazion mia – scriveva – come abbia possuto in Aristarco e nel Copernico far la ragione tanta violenza al senso, che contro a questo ella si sia fatta padrona della lor credulità». E se questa è coscienza dell'umana debolezza...
In molti (in troppi) capirono subito che l'intelletto umano, nonostante i migliori propositi, non si era affatto quietato di fronte all'onnipotenza divina. Al punto di andare a toccare tasti arroventati. Buona parte della quarta giornata del Dialogo era dedicata a discutere le ragioni del famigerato «flusso e reflusso» del mare. Galileo si era interessato al problema da molti anni, probabilmente fin dai tempi di Padova, e già dal 1616 circolava manoscritto un suo Discorso sul flusso e reflusso del mare. Le vere cause del fenomeno non era riuscito a capirle, ritenendo che il moto di marea prendesse impulso unicamente dal movimento della Terra e non avesse alcun legame con l'attrazione lunare, come sostenevano in diversi, Keplero compreso, e come di fatto è. Un elemento in più a favore della sua ipotesi, si direbbe, marginale, e per giunta contestato anche fra i copernicani. Ma perché allora il papa ne aveva così paura da segnalarlo all'attenzione dell'Inquisizione? Fin dall'antichità il «flusso e reflusso» del mare era considerato uno fra gli eventi naturali più misteriosi e incomprensibili, davanti ai quali l'uomo poteva solo arrendersi. Nella tradizione scolastica era addirittura circolata a lungo la leggenda che Aristotele si fosse suicidato per non essere riuscito a scoprirne le cause, e in ambiente cattolico era portato a esempio di quanto l'onnipotenza divina strapazzasse gli scarsi talenti dell'uomo. Affrontare il problema con i mezzi della scienza significava non solo infrangere un tabù secolare, ma, nel caso specifico, contraddire il pensiero del papa. Eppure c'era di più e di meglio. Il «flusso e reflusso» del mare, se Galileo fosse riuscito nel suo intento, rischiava di ammainare la bandiera dell'ipotesi matematica, costituendo la prova fisica della mobilità della Terra. Lo studio delle maree, infatti, non era considerato dominio delle scienze matematiche come la cosmologia, ma competenza della filosofia naturale. Oltretutto Galileo con le osservazioni telescopiche era riuscito fino a quel momento a provare unicamente la falsità di Tolomeo, ma non la verità di Copernico, solo ipotizzata, e il pericolo che ce la potesse fare grazie ai moti del mare non doveva essere sfuggito all'occhio accorto di papa Barberini. Galileo, tuttavia, aveva obbedito agli ordini e non aveva fatto del Dialogo un'opera incentrata sul fenomeno delle maree, né lo aveva nominato nel titolo. Non si era però astenuto dall'esporre dettagliatamente tutta la sua teoria, inserendo il moto di marea fra le più importanti «attestazioni del sistema copernicano». Era stato ben attento a non tacere le idee del papa, citandolo implicitamente, non negando elogi alla «saldissima dottrina» dell'onnipotenza divina appresa «da persona dottissima ed eminentissima… alla quale è forza quietarsi». Solo che a tesserne le lodi era, fra una scempiaggine e l'altra, il semplice Simplicio. Scelta sconsiderata. E l'avrebbe pagata cara.
La lettura del Dialogo strabiliò gli uomini di scienza. Non solo i seguaci più diretti, e non solo in Italia. Fu tutto un infervorarsi, fra lo stupore e l'estasi. Si comprese subito di esser di fronte a una rivoluzione. «Queste novità di verità antiche, di novi mondi, nove stelle, novi sistemi, nove nationi… son principio di secol novo», si complimentava il Campanella col suo solito slancio impulsivo. «Faccia presto Chi guida il tutto. Noi per la particella nostra assecondamo. Amen».
Ma non c'erano solo gli amici. E il «secol novo», almeno in Italia, era di là da venire. Appena all'inizio, avrebbe avuto di lì a poco una repentina battuta d'arresto.
****************************
Scheda a cura di Sara Bonechi
Data aggiornamento 16/gen/2008